
LA VITA
Narrazione analitica della vita | B. Brecht e Galilei

A Pisa il 5 febbraio 1564, dal musicista Vincenzo e da Giulia Ammannati, nasce Galileo Galilei in una famiglia modesta di sei figli. La sua prima formazione, all’età di dieci anni, si svolge presso i monaci camaldolesi, a Firenze. Nel 1581 intraprende gli studi alla facoltà di medicina dell’università di Pavia, ma ben presto si disamora di questo genere, volgendo il suo interesse verso la geometria e la matematica, indirizzatovi dal suo maestro Ostilio Ricci che lo spinge ad approfondire l’opera di Archimede. Nel 1585, senza aver conseguito la laurea, ritorna a Firenze, dove fa qualche ricerca d’idrostatica e con l’insegnamento privato ricava il necessario per il suo sostentamento e per proseguire gli studi matematici; inoltre in questo periodo scrive un lavoro teatrale in cui mette in ridicolo i professori che portavano la toga; in questo modo emerge il suo spirito indipendente. Nel 1589 ottiene un posto come insegnante di matematica a Pisa, ma essendo mal pagato entra in conflitto con la sua università Nel 1592 si trasferisce a Padova, dopo aver insegnato matematica e geometria all’università di Pisa, ottiene la cattedra presso il locale ateneo, la cui facoltà filosofica si basa sull’aristotelismo. Lo scienziato pisano oltre ai colleghi , rispetto ai quali ha una diversa visione del mondo, frequenta ambienti culturalmente più aperti, come casa Pinelli, luogo di incontro tra i più vivaci della repubblica. Collabora a ricerche sul moto naturalmente accelerato con Paolo Sarpi e, inoltre, con Giambattista della Porta e con il cardinale Roberto Bellarmino:

costui, appartenente all’ordine dei gesuiti, svolgerà un ruolo importante nella vita travagliata del nostro autore. Nel 1609 usa, per osservare il cielo, il cannocchiale, messo a punto da poco, e compie importanti scoperte astronomiche (annunciate nel Sidereus Nuncius del 1610) tra cui quella di Giove. Galilei nel 1610 ritorna a Firenze dopo aver ottenuto l’incarico di matematico e filosofo del granduca, che gli avrebbe permesso di proseguire le proprie ricerche senza obblighi di insegnamento. Continua le ricerche col cannocchiale e, anche se contrastato dagli aristotelici che giudicano il telescopio inaffidabile e ingannevole, convalida la teoria eliocentrica di Copernico che poneva il Sole al centro del sistema solare. Intanto il dibattito contro le tesi di Galileo cresceva via via di intensità. Oltre agli aristotelici delle università, si schierano contro Galilei anche i domenicani in quanto fedeli all’aristotelismo cristiano di Tommaso d’Aquino e allarmati dalla mancata concordanza tra l’eliocentrismo copernicano e alcuni passi della Bibbia. Proprio i domenicani (che si considerano i “guardiani” dell’ortodossia cattolica) sono i fautori delle prime denunce all’autorità ecclesiastica contro Galilei. Questa posizione non è condivisa da altri ordini religiosi che, invece, mostrano interesse per le ricerche dello scienziato: tra questi i gesuiti ai quali Galilei, durante una visita a Roma, al Collegio romano, nel 1611 illustra le proprie scoperte. Alcune importanti lettere documentano la posizione assunta dallo scienziato in questi anni; esse, a causa del loro contenuto, sono dette Lettere copernicane; tra queste è opportuno ricordare quelle al collaboratore padre Benedetto Castelli e alla granduchessa madre di Toscana: tra i problemi affrontati da Galilei non c’è solo la difesa alla teoria copernicana, ma anche il rapporto tra fede e scienza. Nel 1616 però anche i Gesuiti mostrano serie perplessità e obiezioni sulla dottrina eliocentrica; viene anche emanato un decreto che vieta di aderire e sostenere la dottrina copernicana: il contenuto di questo decreto viene reso noto a Galileo dal cardinale Bellarmino in persona. La difesa intrapresa da Galilei a favore della teoria eliocentrica viene accantonata in seguito alla condanna del copernicanesimo. Ciò avviene solo per un breve periodo poiché dopo pochi anni lo scienziato è nuovamente impegnato in discussioni pubbliche sul fenomeno delle comete. Nel 1624 pubblica il Saggiatore dedicato al neoeletto papa Urbano VIII, vicino agli ambienti scientifici antitradizionali, sperando che il pontefice favorisca un atteggiamento di maggior apertura nei confronti del copernicanesimo da parte della chiesa e la revisione del decreto del 1616. Da alcuni colloqui con il papa, Galilei sembra trarre l’impressione che la chiesa accettasse questa teoria almeno come ipotesi, ma è ugualmente vero che Urbano VIII era espresso sempre con scetticismo riguardo la possibilità che l’uomo potesse conoscere con verità la natura creata da Dio secondo un progetto a noi inaccessibile. Galileo, nella seconda metà degli anni venti, si dedica alla composizione della sua opera maggiore: il Dialogo sopra i due massimi sistemi, che conclude nel 1630. Tuttavia fu pubblicato solo due anni più tardi, poiché le autorità ecclesiastiche impongono all’autore interventi al fine di smorzare gli accenti troppo esplicitamente favorevoli alla validità del modello eliocentrico, allarmate dall’ evidente interpretazione copernicana che emergeva dallo scritto; solo così viene autorizzata la pubblicazione. Nonostante l’intervento modificatore apportato dallo scienziato al Dialogo,questo venne sottoposto a sequestro pochi mesi dopo la pubblicazione; intanto il Sant’uffizio chiamò Galilei, anziano e malato, a presentarsi, come imputato, di fronte ad un tribunale ecclesiastico. Nella primavera del 1633, a Roma, ha luogo il processo che si conclude, dopo poche udienze, con l’abiura di Galilei al copernicanesimo e con la condanna dello scienziato al carcere perpetuo. Al tempo della discussione sulle comete, i gesuiti erano stati in aperta polemica con lo scienziato, ed è proprio a loro che gli storici fanno risalire l’origine del processo: per impedire la diffusione del Dialogo essi insistono sul contrasto del suo contenuto con il decreto anticopernicano del 1616, sostenendo che dopo l’incontro tra Galilei e Bellarmino, il cardinale aveva impedito allo scienziato di sostenere trattare e insegnare in qualsiasi modo la dottrina eliocentrica.Per i gesuiti la teoria copernicana non può essere sostenuta neppure a livello di ipotesi( come invece aveva ammesso Galilei, al solo scopo di pubblicare la sua opera). La versione del decreto del 1616 proposta dai gesuiti risulta nuova anche per i teologi, nessuno dei quali si oppose alla pubblicazione dell’opera. Inoltre tra i documenti forniti al tribunale dallo stesso Galilei, c’è una dichiarazione autografa di Bellarmino dove viene specificato che il decreto vieta di diffondere e sostenere la teoria copernicana, ma non di trattarla (come invece dice l’accusa). I gesuiti erano però riusciti ad insospettire il papa convincendolo di un presunto inganno di Galilei che, al fine di pubblicare il Dialogo avrebbe tenuto nascosto il vero contenuto del decreto; ciò induce il papa ad adottare una linea estremamente dura nei confronti dello scienziato. Avvenuta la condanna, questa viene presto tramutata in arresti domiciliari. Galilei, ormai ammalato e cieco, trascorre i suoi ultimi anni di vita nella villa di Arretri, nei pressi di Firenze, assistito dal discepolo Vincenzo Viviani. Qui la morte coglie lo scienziato l’8 gennaio del 1642.
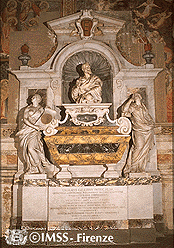
(Sepolcro di Galileo)