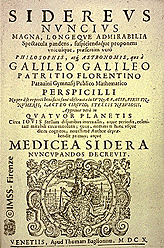
SCOPERTE ASTRONOMICHE
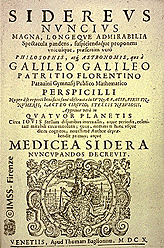
Da Sidereus Nuncius
“[...] Circa dieci mesi fa giunse alle nostre orecchie che
un certo Fiammingo aveva fabbricato un occhiale, mediante il
quale gli oggetti visibili, per quanto molto distanti
dall’occhio dell’osservatore, si vedevano distintamente
come fossero vicini; e di questo effetto, davvero mirabile, si
raccontavano alcune esperienze, alle quali chi prestava fede, chi
la negava. La medesima cosa pochi giorni dopo mi fu confermata
per lettera da un nobile Francese, Jacopo Badovere, da Parigi; il
che fu in fine il motivo che mi spinse ad applicarmi tutto a
ricercarne le ragioni, e ad escogitare i mezzi per i quali io
potessi giungere all’invenzione di un simile strumento;
invenzione che conseguii poco dopo, fondandomi sulla dottrina
delle rifrazioni. E prima di tutto mi preparai un tubo di piombo,
alle cui estremità applicai due lenti, ambedue piane da una
parte, dall’altra invece une convessa euna concava;
accostando poi l’occhio alla concava, scorsi gli oggetti
abbastanza grandi e vicini poichè apparivano tre volte più
vicini e nove volte più grandi di quanto si guardavano con la
sola vista naturale.”
Nel 1609 Galileo mostra ai senatori veneti la sua nuova
invenzione: il
cannocchiale, con il quale riescono a vedere Padova dal
campanile di San Marco; per questo viene premiato con un posto
fisso all’università. In seguito costruisce un altro
cannocchiale che riesce ad ingrandire di venti volte e lo punta
in cielo. Cosi’ scopre un intero cosmo e scrive un libro
sulle sue scoperte astronomiche: il “Sidereus
Nuncius”(Messaggero delle stelle).Nella sua prima
osservazione guarda la luna, le cui strane macchie provano che le
caratteristiche della sua superficie non appaiono poi cosi’
diverse da quelle della terra..Egli suppone che le aree scure
siano mari; poi scopre i crateri e le catene montuose. Riesce a
riconoscere il motivo per cui la linea dell’ombra che scorre
con le fasi lunari attraverso la sua superficie rende ben
visibili le montagne e le valli circolari(così Galileo chiama i
crateri) sparse per tutta la superficie. Galileo descrive queste
montagne e le valli come macchie rotonde, con una frangia nera
sul bordo rivolto verso il sole, mentre l’altro bordo è
illuminato: sono valli circolari, circondate da una catena di
montagne che oggi chiamiamo crateri e l’estensione delle
regioni piatte. Disegna tutto quello che osserva, calcola
l’altezza delle montagne considerando la lunghezza delle
loro onde; per alcune ricava un altezza di 7000 metri che è ben
superiore a quella di tutte le montagne terrestri conosciute
all’epoca. Le osservazioni dopo la luna nuova gli fanno
scoprire la luna cinerea (luce grigiastra che copre il resto
della luna quando la parte illuminata è una falce sottile, poco
prima o poco dopo la fase di luna nuova). Comincia col dimostrare
che questa luce non è prodotta nè dalla luna(altrimenti la si
vadrebbe durante le eclissi) nè dalle stelle, nè dai raggi del
Sole “attravarsanti la luna”, come era stato suggerito
da alcuni autori. Allora la terra illumina la luna che quando
rivolge verso di noi la sua metà all’ombra la terra rivolge
verso la luna proprio la sua metà illuminata: la luce cinerea
non è altro che “ il chiaro di terra sulla luna”! Dopo
aver provato che la luna è montuosa come la terra, Galileo
afferma dunque che quest’ultima è luminosa come la luna,
cioè che l’una e l’altra riflettono la luce del sole.
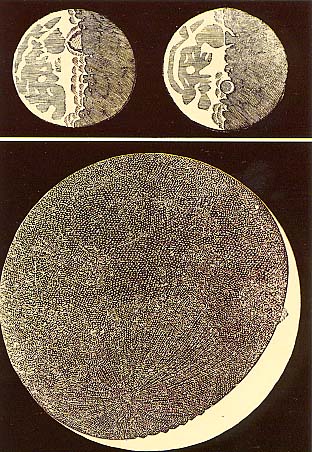
Dall’ Epistolario Lettera a Gallanzone Gallanzoni
Firenze, 16 luglio 1611
[...] Hora, per dire brevemente quanto mi occorre, dico che io ho
sin qui, insieme con tutti i filosofi et astronomi passati,
chiamo Luna quel corpo, il quale, sendo per natura atto a
ricevere et ritenere, senza trasmettere, il lume del sole, alla
vista del quale egli è continuamente esposto, si rende per tanto
a noi visibile sotto diverse figure, secondo che egli è in varie
posizioni situato rispetto al sole et noi, le quali figure, hora
falcate, hora semicircolari et hora rotonde, ci rendono sicuri,
quello essere globoso et sferico: et di questo tale corpo, dal
sole illuminato et da noi veduto, hanno sin qui la maggior parte
de i filosofi creduto che la superficie fosse pulita, tersa et
assolutissimamente sferica; et se alcuno disse di credere che
ella fusse aspra e montuosa, fu reputato parlare più presto
favolosamente che filosoficamente. Hora io di questo istesso
corpo lunare, da noi veduto mediante la illuminazione del sole,
asseriscoil primo, non più per immaginazione, ma per sensata
esperienza et per necessaria dimostrazione, che egli è di
superficie piena di innumerabili cavità et eminenze, tanto
rilevate che di gran lunga superano le terrene montuosità. [...]
ma vengono, in sustanza del loro discorso a dire che la Luna sia
hora non solamente quel globo che noi sensatamente con
gl’occhi veggiamo et sin qui havevamo veduto, ma che, oltre
al veduto da gl’huomini, vi è intorno un certo ambiente
trasparentissimo, a guisa di cristallo o diamante, totalmente
impercettibile dai sensi nostri, il quale, empiendo tutte le
cavità et cimando le più alte eminenze lunari, cinge intorno
quel primo et visibile corpo, et termina in una liscia et
pulitissima superficie sferica, non vietando intanto il passaggio
ai raggi del sole, sì che eglino possino nelle sommerse
momtuosità riflettere et dalle parti avesse causare le
proiezione delle ombre, rendendo intanto l’antica luna il
senso nostro suggetta [...] pur che con pari cortesia sia
permesso a me dire che questo cristallo ha nella sua superficie
grandissimo numero di montagne immense, le quali, per essere di
sustanza diafana, non possono da noi essere vedute et così
potrò io figurarmi un’altra Luna dieci volte più montuosa
della prima. [...]
Nella seconda osservazione guarda il cielo stellato e scopre che
le stelle fisse sono più distanti dei pianeti.
Da Sidereus Nuncius
“[...] Gran cosa è certo l’aggiungere, oltre la
numerosa moltitudine di stelle fisse fino ai giorni nostri si son
potute scorgere con la naturale facoltà visiva, altri
innumerevoli stelle non mai scorte prima d’ora, ed esporle
attentamente alla vista in numero più che dieci volte maggiore
di quelle antiche già note. [...]”
Disegna la costellazione di Orione e si stupisce del gran numero
di stelle visibili.
Costruisce anche una mappa della regione della nebulosa
introducendo nuove stelle; il gruppo delle Pleiadi gliene svela
quaranta.
In seguito punta il cannocchiale sulla via Lattea dove vede
moltissime stelle; con queste scoperte finisce l’epoca del
piccolo cosmo geocentrico e inizia quella della scoperta delle
galassie.
Nel 1610 usa un cannocchiale da trenta ingrandimenti e osserva
Giove puntando la sua attenzione sulle tre stelline più vicine
al pianeta. Le segue per alcune settimane scoprendone una quarta
e nota che esse scompaiono e riappaiono ad intervalli, ma sempre
accompagnando Giove lungo la sua traiettoria celeste. Rappresenta
il pianeta come una lettera “O” un pò schiacciata e
scopre che le quattro stelline sono satelliti che chiama Medicei
in onore della famiglia de’Medici, ma che sono conosciuti
come satelliti galileiani (Io, Europa, Ganimede e Callisto).
Da Sidereus Nuncius
“ Pertanto il girno 7 Gennaio del corrente anno 1610, alla
prima ora della notte, mentre guardavo gli astri celesti col
cannocchiale, mi si presentò Giove; e poichè mi ero preparato
uno strumento proprio eccellente, m’accorsi [...] che gli
stavano accanto tre stelline, piccole invero ma pur lucentissime;
[...] e la loro disposizione sia rispetto loro stesse che a Giove
era la seguente: est**O*ovest
[...] Ma essendo io tornato, non so da quale fato condotto, alla
medesima indagine il giorno 8, trovai una disposizione molto
diversa: erano infatti le tre stelline tutte occidentali rispetto
a Giove est O***ovest
Le due notti seguenti il cielo è nuvoloso, così il 10 Gennaio
osservo: est**O ovest”
Quindi Galileo è chiamato a Roma per le sue scoperte.
Osserva poi le fasi del pianeta Venere, regolari e analoghe a
quelle della luna: ciò può significare che Venere orbiti
intorno al sole e che la sua luce sia riflessa.
Da Galileo Galilei - Lettere, cit. Lettera a Giuliano
de’Medici in Praga
Firenze,1 gennaio 1611
Ill.mo et Rever.mo Sig.re mio Coll.mo, è tempo che io decifri
V.S. Ill.ma e R.ma e per lei al S.Keplero, le lettere trasporte,
le quali alcune settimane sono gli inviai; è tempo, dico, già
che sono interessimamente chiaro della verità del fatto, sì che
non ci resta un minimo scrupolo o dubbio.
Sapranno dunque come, circa tre mesi fa, vedendosi Venere
vespertina, la cominciai ad osservare diligentemente con
l’occhiale, per vedere col senso stesso quello di che non
dubitava l’intelletto. La veddi dunque, sul principio di
figura rotonda, pulita e terminata, ma molto piccola: di tal
figura si mantenne sino che cominciò ad avvicinarsi alla sua
massima digressione, tuttavia andò crescendo in mole. Cominciò
poi a mancare dalla rotondità nella sua parte orientale e aversa
al sole, e in pochi giorni si ridusse ad essere un mezzo cerchio
perfettissimo; e tale si mantenne, senza punto alterarsi, sin che
incominciò a ritirarsi verso il sole, allontanandosi dalla
tangente. Ora va calando dal mezzo cerchio et si mostra
cornicolata, e anderà assottigliandosi sino
all’occultazione, riducendosi allora con corna sottilissime;
quindi, passando ad apparizione mattutina, la vedremo pur falcata
e sottilissima, e con le corna averse al sole; anderà poi
crescendo sino alla massima digressione, dove sarà
semicircolare, e tale, senza alterarsi, si manterràper molti
giorni; e poi dal mezzo cerchio passerà presto al tutto tondo, e
così rotonda si conserverà poi per molti mesi. Ma è il suo
diametro adesso cinque volte maggiore di quello che si mostrava
nella sua prima apparizione vespertina; dalla quale mirabile
esperienza aviamo sensata, e certa dimostrazione di due gran
questioni, state sin qui dubbie tra’ maggiori insegni del
mondo. L’una è, che i pianeti tutti sono di loro natura
tenebrosi: l’altra che Venere necessariamente si volge
intorno al sole, come anco Mercurio e tutto gli altri pianeti,
cosa ben creduta dai Pittagorici, Copernico, Keplero e me, ma non
sensatamente provata, come ora in Venere e Mercurio.[...]Le
parole dunque che mandai trasposte, e che dicevano “Haec
immatura a me iam frustra leguntur o y”, ordinate
“Cynthiae figuras aemulatyr mater amorum”, ciò che è
Venere imita le figure della Luna.
Osservai tre notti sono l’eclisse e nella quale non vi è
cosa notabile:solo si vede il taglio dell’ombra indistinto,
confuso e come annebbiato, e questo per derivare essa ombra da la
terra, lontanissimamente da essa luna.
Favoriscami salutare in mio nome i signori Keplero, Asdale e
Segheti; e a V.S.Ill.ma con ogni reverenza bacio le mani, e dal
S.Dio gli prego felicità.”
Così arriva ad una conclusione: la teoria copernicana è
l’unica in grado di spiegare i fenomeni studiati.
Osserva anche che sulla superficie del sole sono presenti delle
macchie che si spostano con un moto uniforme da ovest ad est,
denunciando che il sole ruota su se stesso. Il periodo di
rotazione osservato dalla terra è di 27,25 giorni. Ma, poichè
in questo tempo la terra percorre quasi un dodicesimo della sua
orbita, il nostro punto di vista cambia; tenendo conto della
necessaria correzione, la rotazione effettiva del sole avviene in
23,35 giorni. In particolare, dallo studio delle macchie solari,
Galileo trae la convinzione che esse consistano in addensamenti
caliginosi analoghi alle nostre nuvole, che offuscano
corrompendolo il disco del Sole, mostrando anche in questo caso,
e in rapporto al più luminoso e perfetto degli astri, quanto
infondata sia l’idea dell’incorruttibilità che
distinguerebbe dalla terra gli altri corpi celesti.
E’ il primo a notare che intorno al globo di Saturno
c’è qualcosa e rimane sconcertato dalle sue osservazioni
telescopiche del pianeta.

Purtroppo nemmeno il migliore dei suoi
cannocchiali ha la potenza ottica sufficiente a mostrare
chiaramente la natura degli anelli. Galileo pensa a due
satelliti. Negli anni seguenti l’anello si dispone di
taglio, rendendo ancora più problematiche le osservazioni di
Galileo. In seguito diversi astronomi cercano di risolvere
l’arcano, ma per questo si deve attendere il 1655, tredici
anni dopo la morte di Galileo.
Da Galileo Galilei-Lettere a Giuliano de’Medici in Praga
Firenze, 13 Novembre 1610
[...] Questo è, che Saturno, con mia grandissime ammiratione, ho
osservato essere non una stella sola, ma tre insieme, le quali
quasi si toccano; sono tra di loro totalmente immobili, e
costituite in questa guisa oOo; quella in mezzo è assai più
grande delle laterali; sono situate una da oriente e l’altra
da occidente, nella medesime linea retta a cappello; non sono
giustamente secondo la drittura del zodiaco, ma la occidentale si
aleva al quanto verso borea; forse sono parallele
all’equinoziale: Se si riguarderanno con un occhiale che non
sia di grandissime moltiplicazione, non appariranno tre stelle
ben distinte, ma parrà che Saturno sia una stella lunghetta in
forma di una uliva; ma servendosi di un occhiale che moltiplichi
più di mille volte in superficie, si vedranno li tre globi
distintissimi, e che quasi si toccano non apparendo tra essi
maggior divisione di un sottil filo scuro. Or ecco trovata la
corte a Giove, e due servi e questo vecchio, che l’aiutano a
camminare nè mai se gli staccano dal fianco.[...]
Nel Dicembre 1612 e nel Gennaio 1613, mentre osservava Giove, il
pisano registrò una stella vicino a Giove: Nettuno! Galileo
scrive che secondo lui la posizione di questa stella vari.
Esprime le sue opinioni anche nel “Saggiatore” nel 1613
che contiene un’interpretazione non corretta del fenomeno
delle comete.