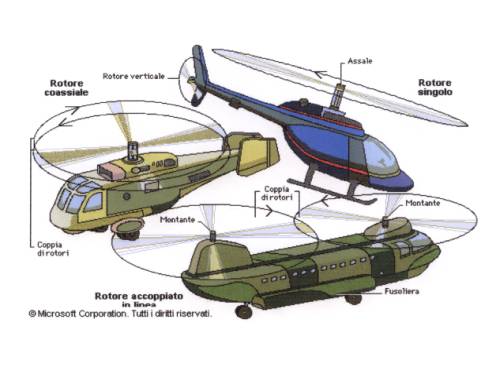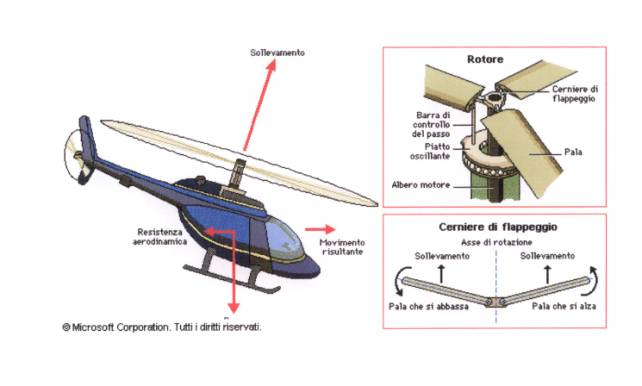L'elicottero

Il Modello
Il progetto della "vite aerea" o elicottero, descritto nel codice B f.83v.
È un progetto in cui l'unicità del disegno impedisce raffronti ed
integrazioni. Sembrano sovrapporsi nello schizzo dell'idea, accennata
nell'appunto che l'accompagna, di un modello preliminare azionato da una
molla e l'idea dell'apparecchio definitivo, mosso presumibilmente dalle
braccia di quattro uomini che camminano sulla piattaforma centrale. Quest'ultima
è stata quindi concepita come ferma rispetto all'albero ed al castello
esterno, i quali ruotano insieme essendo vincolati dai cavi di rinforzo della
spira. Il raggio della vite definitiva doveva essere di otto braccia
fiorentine, corrispondenti a sessanta centimetri l'uno. Quanto al fatto che,
non appena staccato dal suolo, l'apparecchio cesserebbe di funzionare perché
privo di un vincolo che si opponga al momento torcente dell'elica si
ipotizza che il progetto di Leonardo fosse soltanto inteso a misurare
l'efficienza trattiva di questa vite, che in tal caso non avrebbe dovuto,
però, venire concepita da lui come capace di «farsi la femmina nell'aria e
montare in alto».
I modellini sperimentati con successo tra il 1784 e il 1796 da Launay in
Francia e da Cayley in Inghilterra sembra sfruttassero, invece, la struttura a
due eliche quadripale contrapposte dell'antichissima "trottola aerea"
cinese; di tali eliche è stata prospettata, a loro volta, una possibile
derivazione dal "boomerang" australiano avente la stessa forma.
Il migliore commento al disegno di Leonardo resta comunque il testo di
Leonardo che lo accompagna:
La stremità di fori della vite sia di filo di ferro grosso una corda, e
dal cerchio al centro sia braccia 8 [circa 5 metri]. Truovo, se questo
strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con
prestezza, che dette vite si fa femmina nell'aria e monterà in alto. Piglia
lo esenplo da una riga larga e sottile, e menata con furia in fra l'aria:
vedrai essere guidato il tuo braccio per la linia del taglio della detta asse.
Sia l´armadura della sopra detta tela di canne lunghe e grosse. Puosseno fare
uno picciolo modello di carta, che lo stile suo sia di sottile piastra di
ferro, e torta per forza, e nel tornare in libertà fa ravvolgere la vite".
Breve
storia dellElicottero
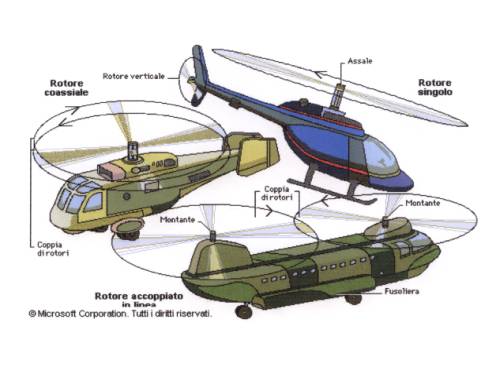
Conosciuto da Archimede e nell'antica Cina, il principio
secondo cui la rotazione di una superficie portante elicoidale può far
sollevare in volo un oggetto pesante trovò applicazione in una macchina volante
disegnata alla fine del XV secolo da Leonardo da Vinci. Nel 1784 i francesi
Lannoy e Bienvenue realizzarono i primi modellini a molla, seguiti da analoghi
prototipi realizzati alla fine del XIX secolo dal francese Renard e
dall'italiano Enrico Forlanini. Al 1906 risale il volo del primo elicottero
con equipaggio, effettuato a Lisieux, in Francia, dal francese Paul Cornu.
L'impresa fu replicata l'anno successivo da Louis Breguet e dal professor
Richet. Nel 1930, dopo i progressi compiuti in Europa da Raoul Pescara, Etienne
Oehmichen, Jacob Christian Ellehammer e dagli statunitensi Emile e Henry
Berliner e George de Bothezat, l'italiano Corradino D'Ascanio compì una
serie di voli di durata considerevole con un elicottero da lui ideato, aprendo
la strada al primo elicottero moderno, il Focke‑Wulf tedesco pilotato
dall'aviatrice Anna Reitsch. Dopo il 1939 i maggiori progressi furono ottenuti
dall'ingeniere russo Igor I. Sikorsky, con i modelli VS‑300 e XR‑4,
che nel maggio 1942 percorsero 1225 km che separavano la località di Stratford,
nel Connecticut, da Dayton, nell'Ohio. Nel 1967 due elicotteri Sikorsky HH‑3
volarono da New York a Parigi rifornendosi in volo.
L'Elicottero
attuale: il rotore
Le pale di un elicottero, che hanno una forma aerodinamica simile alle ali
di un aeroplano e si sollevano in base allo stesso principio, sono inserite in
meccanismo rotore che permette il movimento in tutte le direzione e il volo a
punto fisso. La rotazione della pala produce una spinta verso l'alto che vince
il peso del velivolo e la resistenza aerodinamica. Variando l'angolo di taglio
della pala, detto angolo di passo, l'elicottero sale o scende assorbono la
differenza di portanza tra le pale anteriori e quelle posteriori rispetto alla
direzione di avanzamento, evitando così lo squilibrio aerodinamico del
velivolo. Per contrastare la coppia di reazione, ossia l'effetto per cui il
velivolo tende a girare nel verso opposto a quello delle pale, negli elicotteri
a rotore singolo è montata una piccola elica verticale sulla coda, mentre in
quelli a doppio rotore le due eliche ruotano in verso opposto. L'agilità e il
controllo dei movimenti verticali rispetto a quelli di un aereo fanno sì che
siano necessari carrelli o pattini di atterraggio meno sofisticati.