
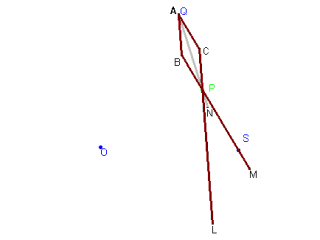
Tra
gli studi di Leonardo da Vinci di particolare importanza fu uno studio del
sistema nervoso in cui si proponeva di capire il funzionamento degli organi di
senso. Nella concezione tradizionale, il cervello conteneva tre cavità: la
prima, l'impressiva, raccoglieva le informazioni provenienti dai cinque
sensi. Queste informazioni venivano passate al cervello, il sensus comunis,
dove erano interpretate, e poi depositate nel terzo ventricolo, la memoria.
La vista
Tra i cinque sensi Leonardo collocò la vista al vertice della gerarchia sensoriale, descrivendola come il mezzo più importante in nostro possesso per comprendere gli infiniti meccanismi della natura.
Ai tempi di Leonardo la comprensione dell'ottica era ancora aggrappata alle false convinzioni di Aristotele e Platone. L'errore più evidente era l'idea platonica che gli esseri umani percepissero l'universo perché l'occhio proiettava particelle che venivano poi nuovamente riflesse all'occhio.
Leonardo
si rese conto che questa ipotesi era illogica, e pervenne alla conclusione che
se la vista avesse funzionato in quel modo , allora noi avremmo potuto vedere
tutti gli oggetti con la stessa velocità perché le particelle emesse
dall'occhio impiegherebbero tempi deformi per raggiungere obbiettivi a
distanze diverse e tornare poi ai nostri occhi.
Dopo
numerosi studi sostituì questa teoria con una semplice descrizione, affermando
che la luce si comporta come un'onda. Leonardo poi proseguì descrivendo il
modo in cui la luce è riflessa da superfici diverse, il meccanismo con cui
l'occhio percepisce i riflessi, giudica le distanze e riconosce le
prospettive, e quello in cui la luce, cadendo sugli oggetti, genera le onde.
In
gran parte del pensiero di Leonardo sentiamo riecheggiare il grande filosofo
arabo Alhazen, il quale all'inizio di Prospectiva communis osserva:
tra tutti gli studi delle cause e delle motivazioni
la luce massimamente delizia i contemplatori; tra le grandi cose della
matematica, la certezza delle sue dimostrazioni eleva la mente dei ricercatori
nel modo più illustre;la prospettiva deve dunque essere preferita a tutti i
discorsi e le discipline umane, nello studio della quale i raggi si espandono
per mezzo delle dimostrazioni e in cui si trova la gloria non solo della
matematica ma anche della fisica, contemporaneamente adorna dei fiori dell'una
e dell'altra.
Nei
suoi taccuini, Leonardo tradusse dal latino questo passaggio che rappresenta
perfettamente il suo punto di vista sull'ottica.
Pecham e
altri pensatori medioevali avevano sostenuto che il vuoto fosse riempito dalle
immagini provenienti da oggetti solidi. Secondo costoro, come per Leonardo, ogni
corpo opaco riempiva l'aria circostante con infinite immagini: in poche parole
e"la luce viene riflessa in tutte le direzione da tutte le parti degli
oggetti solidi opachi e viaggia in linea retta".
Pecham
introdusse il concetto di "piramide" per riferirsi alla traiettoria dei
raggi luminosi dall'oggetto all'osservatore; esso fu in seguito adottato
dall'Alberti e poi ripreso da Leonardo. Nei suoi taccuini,
in cui egli parla della luce, si presenta il termine piramide
radiante o piramide ottica. L'espressione si riferisce all'idea che i
raggi di luce provenienti dai bordi di un oggetto e che convergono con quelli
che viaggiano esattamente in linea retta, li intersecano a livello
dell'occhio, al quale giungono sotto forma di una piramide o di un cono. Tale
idea era basata sull'assunto che la luce viaggi in linea retta; Leon Battista
Alberti l'aveva estesa per spiegare il modo in cui l'artista raccoglie
informazioni da un oggetto.
Leonardo
si servì di alcune parti del lavoro di Alberti per giungere alle proprie
conclusioni.
Collegando
il funzionamento dell'occhio a quello della camera oscura, Leonardo procedette
creando strani congegni ottici in grado di aumentare l'ampiezza del campo
visivo; a tal proposito scriveva:
se torrai una mezza palla di vetro e metteravvi
dentro il volto e stopperella bene alla
congiunzione del viso e empierella di sottile acqua, vederai tutte le
cose che son vedute dalla superficie d'essa palla, in modo quasi ti vederai
dirieto alle spalli.
Questi
studi lo condussero infine al progetto del proiettore e alla costruzione di un
congegno affine a un cannocchiale.
Leonardo
si rese conto che dai tempi degli antichi Greci la teoria dell'ottica aveva
conosciuto pochi sviluppi, così si prefisse di formulare una nuova teoria della
luce.
La
prima conclusione originale di Leonardo fu che la velocità della luce avesse un
valore finito.
Nel
manoscritto F egli spiega che se si chiudono gli occhi e poi li si riaprono, la
luce che si vede non è più quella di prima, cioè che quella che era un
istante fa ora non è più.
Per
confutare l'ipotesi delle particelle emesse dall'occhio sostiene che se
davvero il meccanismo della vista fosse quello, aprendo gli occhi non sarebbe
possibile vedere immediatamente gli oggetti lontani. Inoltre le particelle
potrebbero essere deflesse dal vento, come accade ai profumi. Aggiunge che la
luce dovrebbe avere il tempo necessario per viaggiare da una sorgente ai nostri
occhi.
Solo
nel 1697, osservando l'eclissi dei satelliti di Giove, l'astronomo Olaus
Roemer scoprì che la velocità della luce è finita.
A
partire dal suo studio, Leonardo arrivò a un'altra conclusione; mentre gli
antichi sostenevano l'idea che per giungere a qualsiasi conclusione la natura
seguisse sempre la via più facile e veloce. Partendo da tale convinzione,
Leonardo concluse che ogni azione ha luogo seguendo la via più breve. A questa
conclusione egli era giunto partendo dalla scoperta della velocità della luce.
Da
Vinci capì chiaramente che la luce e il suono potevano viaggiare attraverso un
mezzo, mediante quel che descrisse come tremito o una vibrazione, un processo
che una volta innescato si ripete trasmettendo un segnale da un punto a un
altro, attraverso la propagazione.
se getterai in un medesimo tempo due piccole
pietre alquanto distanti l'una dall'altra sopra un pelago d'acqua senza
moto, tu vedrai causare intorno alle dette due pietre due sparate quantità di
circoli, le quali quantità accrescendo, vengono a scontrasi insieme;(.) E la
ragione è, che, benché ivi apparisca qualche semostrazione in movimento,
l'acqua non si parte dal suo sito; perché l'aperture fatte dalle pietre
subito si richiusero, e quel moto fatto dal subito aprire e serrare dell'acqua
fa in lei certo riscotimento, che si può più tosto dimandare tremore che
movimento. E che quello che io dico ti si facci più manifesto, poni mente a
quelle festuche, che per loro leggierezza stanno sopra l'acqua, e vederai, che
per l'onda fatta sotto loro per
l'accrescimento dei circoli, non si partono però dal loro sito. Essendo
adunque questo tale risentimento d'acqua piuttosto tremore che movimento, non
si possono, per incontrarsi, rompere l'un l'altro, perché, avendo l'acqua
tutte le sue parti d'una medesima qualità, è necessario che le parti
attacchino esso tremore l'un l'altra, senza mutarsi dal loro luogo, perché,
stando l'acqua nel suo sito, facilmente può pigliare esso tremore dalle parti
vicine, e porgerle all'altre vicine, sempre diminuendo sua potenza insino alla
fine.
Egli non vedeva alcuna differenza nel modo di comportarsi delle onde dell'acqua, del suono o della luce. In effetti, fedele alla sua ricerca a volte esasperata di un' "unificazione" nella natura, Leonardo si spinse troppo oltre e cercò di collegare l'odore alla luce e al calore, dichiarando:
Si prova nel sole, il quale manda fori di sé di 2
ragioni spezie: la prima luminosa, l'altra del calore. (.) Che l'aria si
attragga a sé come calamita tutte le similitudine delle cose che la circundano,
né che le forme de' corpi ma ancora le nature, chiaramente s vede nel sole,
il quale è corpo caldo e luminoso. Tutta l'aria che li è per obietto, tutta
per tutto s'incorpora di lume e di calore e tutta riceve in sé la forma della
cagione del calore e splendore e in ogni minima parte fa il simile. La
tramontana dimostra per la calamita fare questo medesimo e luna e altri pianeti
senza diminuzione da sé fa il simile. Infra le cose terrestre è fatto il
simile dal moscato e altri odori.
Leonardo
anticipò Christiaan Huygens, che pubblico una sua teoria della natura
ondulatoria della luce nel 1690.
Huygens
non fece alcun cenno a un'onda trasversale provocata da una vibrazione, che è
appunto quanto Leonardo descrive nel lungo passo citato sopra sulle increspature
formate sulla superficie dell'acqua da un sasso lanciatovi dentro. Benché
Leonardo non usi un termine preciso come onda trasversale, la sua descrizione è
ugualmente completa e accurata.
In
effetti, Huygens poteva benissimo essere a conoscenza del lavoro di Leonardo,
perché qualche mese prima della pubblicazione del suo lavoro, aveva ricevuto
una lettera dal fratello Costantino, il quale gli comunicava di aver comprato un
manoscritto di Leonardo e in seguito gli forniva una breve descrizione del
contenuto del documento , in particolare, delle descrizioni sulla prospettiva e
delle teorie sulla luce e l'ombra.
Nel
1491 Leonardo mise mano al suo primo taccuino in cui esplora la natura della
luce e delle ombre e si pone degli interrogativi sul loro comportamento,
fornendo poi alcuni suggerimenti per la costruzione di congegni ottici e
riportando le sue ricerche sulla natura di fenomeni quali riflessione e
rifrazione. Questo documento è oggi conosciuto come manoscritto C.
A
Leonardo venne l'idea di osservare che cosa succede quando la luce passa
attraverso un prisma improvvisato, forse perché si era imbattuto per caso in
una manifestazione naturale del fenomeno. Questa osservazione era già stata
fatta da molti prima di lui.
Egli
disegnò un'accurata rappresentazione di quanto aveva osservato, prese nota
delle sue scoperte poi cercò di collocarle nel sistema dell'ottica che si
andava sviluppando.
Leonardo
studiò anche il fenomeno della rifrazione, lo descrisse e basandosi su una
serie di esperimenti ampliò le rudimentali osservazioni compiute nell'XI
secolo da Alhazen.
Da
questo Da Vinci riprese anche lo studio oggi noto come problema di Alhazen.

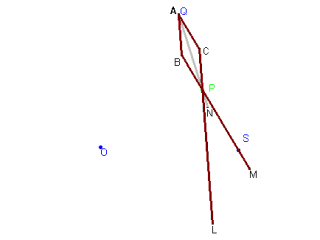
Nella
prima asta, imperniata in Q (fisso sul piano), è praticata una scanalatura ove
scivola il cursore A, al quale sono incernierate due aste uguali AB, AC. Altre
due sbarre BM e CL (incernierate in B, C) si intersecano su un perno P (QP=cost.),
formano un rombo articolato ABPC e sorreggono (nei tratti PM, PL) due
scanalature. PM scivola attraverso un cursore S (fisso sul piano) che
rappresenta la sorgente. Spostando PL fino a farla passare per l'occhio O, si
risolve automaticamente il problema.
*Per
la risoluzione del problema Leonardo fece una macchina chiamata ELLISSIOGRAFO DI LEONARDO.
Il rombo
articolato OABC ha il vertice O imperniato al piano del modello e il vertice
opposto B vincolato a scorrere lungo la guida rettilinea g passante per
O. Muovendo B lungo g, si osserva che i punti A e C descrivono, insieme,
la semicirconferenza di centro O e raggio OA mentre ogni altro punto P
dell'asta a (oppure Q dell'asta b) descrive la quarta parte di
un'ellisse con centro in O e assi di simmetria coincidenti con g e con
la retta r perpendicolare a g condotta per O. I punti E ed F
rispettivamente delle aste a e b tali che AE=CF=OA descrivono
un'ellisse degenere in un segmento della retta r.
Un secolo
prima Leonardo aveva già descritto perfettamente l'effetto:
Per
vedere come li razzi solari penetrar questa curvità della spera dell'aria, fa
fare due palle di vetro, maggiori due volte l'una dell'altra e che sian più
tonde. Po' che taglia per mezzo e commetti l'una nell'altra e chiudi le
fronti e empi d'acqua e falli passar entro il razzo solare, come di sopra
facesti, e guarda se tal razzo si piega o si incurva e favvi su regola. E così
puoi fare infite esperienze.
Il
colore del cielo è un altro fenomeno spiegabile facendo ricorso ai principi
dell'ottica. Nel codice Leicester, scriveva:
dico l'azzurro, (che) in che si mostra l'aria,
non essere suo proprio colore, ma è causato da umidità calda, vaporata in
minutissimi e sensibili attimi, le quale piglia dopo se la percussion de'
razzi solari e fassi luminose sotto la oscurità delle immense tenebre della
regione del fuoco, che di sopra le fa coperchio.
Anche
questo studio verrà approfondito da altri fisici e matematici anni dopo, ma
Leonardo, come per quasi tutte le sue scoperte, anticipò di molto i tempi.