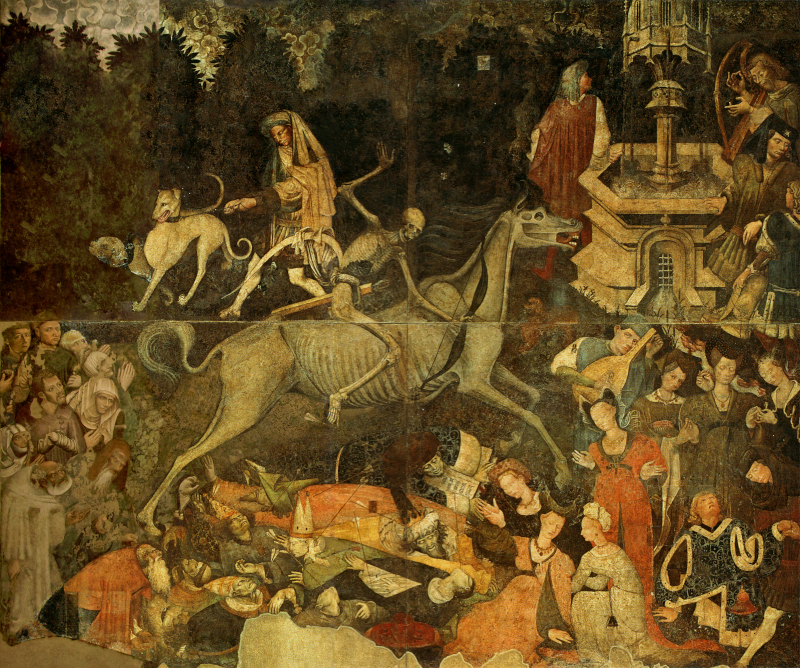I poveri c’erano allora, come adesso. L’epoca di cui parliamo è il Trecento, anni caratterizzati da una profonda crisi, economica, demografica e sociale. Ma come venivano trattati allora i poveri?
Una profonda contraddizione segnava la società: se da una parte i poveri erano cacciati e considerati malvagi, dall’altra essi costituivano un modo per redimersi dai propri peccati. Le ingiustizie che subìvano erano molte: spesso non potevano neppure avere alloggio negli asili di una stessa città per due notti di fila, pena la forca. Il povero era isolato: non aveva nome, né documenti, e anche dopo la morte era separato dagli altri, in fosse comuni. Ma riceveva nello stesso tempo asilo e aiuti da ospedali, confraternite e corporazioni. I mercanti istituirono il “conto di messer Domeneddio”, che raccoglieva le elemosine concesse ai poveri. Oltre alle singole corporazioni, che prevedevano sostegno e assistenza in favore dei membri in difficoltà, i poveri erano anche ricordati nei lasciti testamentari: non c’era miglior mezzo infatti per espiare i propri peccati.
Penso ora a ciò che succede nel presente. Anni luce lontano dal Trecento, sembra. Eppure, i mendicanti che supplicano per pochi euro, che giacciono ai lati delle strade, scansati dai passanti, raccontano un’altra storia. Il modo in cui essi sono oggi trattati è così diverso da quello del Trecento? Di sicuro c’è una maggior sensibilizzazione nei loro confronti: non sono più considerati malvagi o cacciati con brutalità dalle città. Ma se nel Trecento essi erano anche sofferenti da aiutare, anche solo per la salvezza della propria anima, ora non è più così: i più poveri ed i mendicanti guardano dal basso della loro posizione i passanti, che, il più delle volte, li ignorano, imbarazzati dalla sporcizia e dalla ripugnanza in cui vivono, ma troppo lontani dalla loro realtà per allungare una mano in loro aiuto. Certo, le organizzazioni umanitarie tentano di rendere le loro condizioni più sopportabili, ma la maggior parte delle volte questo non è sufficiente. Nel Trecento, benché l’obiettivo fosse puramente egoistico, un aiuto veniva fornito anche dalle persone comuni.
Ed allora io mi domando: possibile aver fatto un passo indietro rispetto ad un’epoca in cui gli ebrei e i lebbrosi erano accusati e perseguitati perché considerati gli untori che diffondevano la peste?