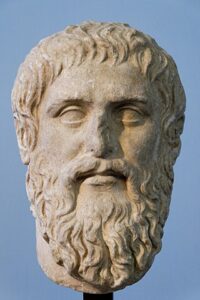Tommaso d’Aquino, nato intorno al 1225 e morto il 7 Marzo 1274, è ritenuto uno dei maggiori pensatori del Medioevo. Egli era un domenicano che ispirò la sua riflessione teologica alla dottrina del filosofo greco Aristotele, cercando di conciliarla con la tradizione cristiana.
San Tommaso aveva una concezione unitaria del sapere: riteneva che la filosofia e la teologia fossero due ambiti strettamente connessi.
Ciò contrastava con le convinzioni diffuse in quel periodo, secondo le quali esse erano due attività intellettuali distinte poiché la filosofia spesso si opponeva ad alcuni concetti cristiani; in particolare molte autorità civili ed ecclesiastiche avevano tentato di censurare la dottrina aristotelica, ma ciò ebbe uno scarso successo, dato che essa continuò ad influenzare e affascinare il mondo medievale.
Inoltre bisogna considerare che nel mondo latino, molto più che nel mondo arabo, vi erano numerosi seguaci (tra i quali spicca Boezio di Dacia) dell’averroismo, ossia il pensiero filosofico e scientifico di Averroè e della sua scuola. Esso affermava tra le sue tesi la subordinazione della fede alle verità di ragione (ritenuta l’unico organo idoneo ad acquisire conoscenze scientifiche), l’eternità della materia e del mondo, l’unicità dell’intelletto possibile per tutti gli uomini (definita “monopsichismo”). Molti suoi seguaci però non concordavano con il commentatore arabo a proposito del rapporto fede – ragione, affermando la loro separazione, ma non contrapposizione (in quanto le verità razionali possono essere in contrasto, ma non invalidare le verità rivelate). Gli averroisti latini affermavano il primato della fede sulla ragione e distinguevano i principi, i mezzi e gli ambiti da cui derivavano le conclusioni divergenti. Questa posizione fu osteggiata da molti pensatori medievali come Bonaventura e lo stesso Tommaso d’Aquino, che vedevano in essa il pericolo di cadere in una doppia verità. Quest’ultima è una dottrina attribuita proprio ad alcuni scolastici medievali, secondo la quale devono essere considerate simultaneamente vere una conclusione raggiunta dalla ricerca filosofica e una contraria accettata per fede . Averroè fu a lungo considerato il fautore di questa dottrina, ma in realtà egli sostenne che religione e filosofia hanno funzioni e destinatari differenti: la prima esprime la verità per l’azione e prepara allo studio della seconda, la quale, avendo di mira la speculazione, può riguardare un numero di persone più limitato. Dunque la verità è una sola, ma diverso è il modo di conoscerla.
Il maestro di Tommaso, Alberto Magno, sosteneva la tesi delle autorità, considerando che la fede si basa sulla rivelazione divina, mentre la ragione si può occupare solo di quanto le è accessibile; però egli pensava che si dovesse avere il diritto di studiare anche la fisica e la filosofia aristotelica per capire meglio le leggi che governano il mondo naturale.
Tommaso d’Aquino riconosce che teologia e filosofia partono da premesse differenti, perché la prima inizia la sua indagine e riflessione da verità accolte, a cui si crede per fede, al contrario la seconda analizza fenomeni e concetti evidenti, che si possono raggiungere razionalmente. Egli però ritiene che esse si servano dello stesso metodo scientifico, ossia il criterio aristotelico, per giungere a delle conclusioni; quindi non ci possono essere contraddizioni tra la scienza teologica e quella filosofica, ma nel caso in cui esse esprimano tesi contrastanti, Tommaso afferma che la teologia è superiore in quanto i suoi principi sono infallibili perché ottenuti dalla rivelazione divina, dunque la contraddizione è data da un uso scorretto della ragione, che può arrivare a conoscere da sola esclusivamente una parte dei dogmi affermati nelle Sacre Scritture.
Inoltre secondo San Tommaso la teologia deve fornire un sommo sapere speculativo e pratico, mentre la filosofia ha il compito di dimostrare la non contraddittorietà dei preamboli di fede (come l’affermazione dell’esistenza di Dio, la definizione di esso, dei suoi attributi e l’immortalità dell’anima), deve combattere eventuali posizioni contrarie ad essa e infine chiarire i misteri della fede attraverso analogie e similitudini. Tutte queste funzioni configurano la filosofia anche come una teologia “naturale”.
Dunque egli ritiene che, oltre ad alcuni contenuti religiosi inaccessibili per la ragione umana, ve ne sono altri che essa può arrivare a conoscere e approfondire razionalmente.
Rispetto a visioni tetre, cupe come quella incarnata da San Pier Damiani, il cui centro è la visione religiosa del mondo, la superiorità di essa rispetto ad ogni elemento e il disprezzo delle questioni umane e terrene, Tommaso appare come un innovatore perché egli comprende che non si può credere nell’assurdo, ma che anzi fede e ragione debbono necessariamente collaborare; San Tommaso sostiene dunque il principio formulato da Sant’Agostino “Credo ut intelligam, intelligo ut credam” (“Credo per comprendere, comprendo per credere”). Per questo il teologo domenicano rivaluta il corpo e il mondo terreno.
Il rapporto fede – ragione è stato a lungo oggetto d’indagine, analisi e discussione per diversi filosofi e teologi, ma in realtà esso è stato, è e probabilmente sarà un tema di riflessione per tutti gli uomini di ogni periodo storico, anche nella società attuale.
Io penso che questo sia un argomento molto delicato, che coinvolge tutti in prima persona e su cui è difficile, anzi impossibile, trovare considerazioni condivise.
In una società laica come la nostra, la cultura e il modo di pensare stanno diventando sempre più autonomi dalla religione; ciò porta a credere che la teoria esposta da San Tommaso sia difficile da mettere in atto, perché mentre la fede esprime assiomi ritenuti veri per fiducia nella rivelazione divina, invece la ragione si basa, come detto, solo su elementi logici, deducibili dalla diretta osservazione e dall’esperienza di ognuno di noi.
Inoltre personalmente non ritengo che entrambe siano improntate ad un metodo scientifico, perché esso richiede dei principi evidenti e universalmente noti, quindi può esserlo solo la filosofia, la ragione (anche se Tommaso afferma che la teologia è una scienza perché i principi religiosi acquistano un’evidenza speciale agli occhi del credente, anche perché essi derivano dalla conoscenza che Dio ha di se stesso, trasmessa agli uomini attraverso la rivelazione). Poi ci sono casi in cui esse cadono in contraddizione tra di loro, giungendo a conclusioni divergenti; di ciò era consapevole anche Tommaso e, proprio per questo, egli capì che per esporre il suo pensiero era necessario trovare un punto d’incontro per entrambe e conciliarle (e lo fece infatti affermando che anche la teologia è una scienza).
Nonostante ciò, come afferma Tommaso, sia teologia che filosofia cercano di raggiungere conclusioni veritiere e penso che non si possa negare che esse sono in continuo contatto, confronto e si influenzano a vicenda, perché comunque bisogna considerare che la nostra razionalità si trova a vivere e operare in un contesto di tradizioni e usanze fortemente caratterizzate dalle credenze religiose.
L’attualità del pensiero di Tommaso d’Aquino si può riscontrare anche nella lettera enciclica “Fides et Ratio”, promulgata da Papa Giovanni Paolo II nel 1998. In essa egli afferma che “La Fede e la Ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità”. Con questa metafora, il Papa spiega che fede e ragione non si escludono, ma al contrario si completano e si sostengono a vicenda. Spesso l’uomo tende ad utilizzare una sola delle due ali, trovando poi difficoltà a proseguire nel percorso di ricerca della verità, perché quest’ultima può essere raggiunta solo con il dialogo e l’interazione tra fede e ragione (che da sole risultano incomplete). Il Papa inoltre spiega che inizialmente l’uomo non riesce a trovare risposte razionali alle verità religiose rivelate, quindi è necessario in un primo momento invocare la fede per proseguire successivamente la ricerca della verità con l’intelletto, che è indispensabile per capire le rivelazioni divine, che dunque non vanno accettate, ma conosciute, pensate e analizzate dalla ragione.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...