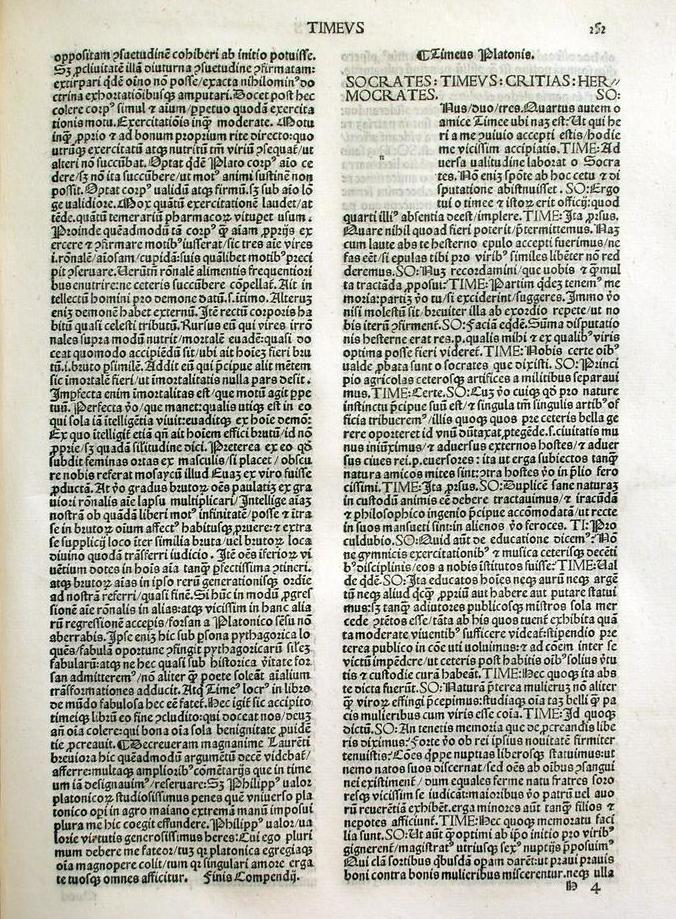Francesco Bacone visse tra il 1561 e il 1626. Fu una personalità decisiva nella nascita del pensiero scientifico moderno. Non contribuì direttamente alla realizzazione delle numerose scoperte del Seicento, ma fu importante per la sua concezione innovativa della scienza.
Proponeva una stretta collaborazione tra le arti liberali (il sapere teorico) e le arti meccaniche (il sapere tecnico): un sapere collettivo, in continuo progresso, teso a scoprire i processi della natura.
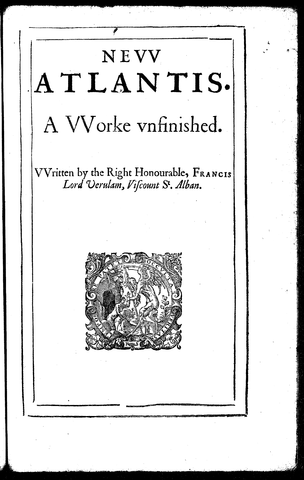
Secondo me è interessante soffermarsi sulla sua opera utopistica, La Nuova Atlantide. Il libro non presenta i temi tipici delle tradizionali opere di utopia politica (la migliore forma di governo, il ruolo delle magistrature, la funzione della nobiltà, l’educazione del principe). Si può invece meglio definire come un’opera di messianismo profetico, di sociologia utopistica o, per utilizzare un termine più corretto ai giorni nostri, di futurologia.
Bacone colloca la sua comunità ideale nell’isola di Bensalem. Essa è caratterizzata da tolleranza nei confronti di ogni religione (anche se c’è una fede ufficialmente professata, quella cristiana), da un alto tenore di vita, da ricchezza e benessere diffuso (evidente nelle cerimonie e nelle festività, celebrate sempre con solennità). Di conseguenza è presente una comune serenità e concordia civile tra tutti gli abitanti, che tra di loro assumono un comportamento generoso, cortese e rispettoso. Inoltre a Bensalem è ritenuta fondamentale l’austerità dei costumi e l’integrità degli abitanti. A ciò è dovuta la condanna della prostituzione, dell’omosessualità e di ogni genere di comportamento dissoluto attraverso l’applicazione di rigide norme morali.
Infine la comunità descritta da Bacone concepisce il matrimonio come un vincolo esclusivamente monogamico, che ha come scopo la procreazione e implica una pena ereditaria nel caso venga contratto senza il consenso dei genitori.
Un altro tema importante, anzi il principale, trattato dal filosofo ne La Nuova Atlantide è il rapporto tra scienza e politica. Infatti nella civiltà ideale di Bacone agli scienziati viene affidata una funzione specifica: essi vivono separati dal potere politico e dal resto dei cittadini e lavorano in solitudine, in luoghi tranquilli dove possono sviluppare ricerche e scoperte scientifiche. Inoltre gli scienziati possono decidere se le scoperte realizzate debbono essere rese note o meno al resto degli abitanti di Bensalem e, nel caso vengano nascoste ad essi, se possono essere rivelate agli organismi politici o tenute segrete anche a questi ultimi. Infatti, per Bacone, anche in una società così pacifica bisogna cautelarsi sull’eventuale uso indiscriminato e pericoloso che il potere pubblico potrebbe fare delle ricerche tecnologiche. Il filosofo inglese poi, oltre a porre una distinzione netta tra attività scientifica e politica, separa fortemente l’ambito della religione dalla scienza, affermando che solo l’etica e la religione si devono occupare di stabilire i valori corretti a cui attenersi.
Dunque Bacone ha assunto un ruolo fondamentale nella storia della filosofia perché ha valorizzato la scienza e la tecnologia, capendo che esse permettono un’evoluzione positiva delle condizioni della vita umana. Infatti egli ha affermato che la conoscenza degli uomini è limitata dagli idola (le superstizioni, i pregiudizi, le immagini) e dalla tradizione magica, che Bacone reputa un sapere fantastico, segreto, superstizioso, indifferente al bene pubblico e quindi da respingere. L’uomo deve essere ministro e interprete della natura, ma l’unica via da seguire è la scienza.
Personalmente credo che il pensiero filosofico di Bacone sia molto attuale. Infatti egli tratta temi che possono costituire spunti di riflessione in ogni epoca e in ogni luogo.
Anche oggi la nostra conoscenza è spesso viziata da superstizioni e preconcetti. Sebbene non siano più diffuse come un tempo le credenze magiche, tutti abbiamo dei pregiudizi, che ci convincono di cose sbagliate e ci inducono in errore, allontanandoci dalla conoscenza della verità.
Venendo all’argomento principale che ho trattato, il rapporto tra scienza e politica descritto da Bacone ne La Nuova Atlantide, bisogna tener ben presente che le sue riflessioni sono circoscritte ad una civiltà ideale. Sebbene non sia un testo di utopia politica, ma di futurologia, questo libro presuppone una società inarrivabile, lontana dalla realtà concreta. La comunità di Bensalem è un modello di civiltà serena e pacifica, ma non sono tanto la concordia civile e il rispetto reciproco ad essere difficili da realizzare, bensì gli elementi che li determinano: in una società in crisi come la nostra, sembra impossibile pensare ad una ricchezza e un benessere diffusi tra tutti i cittadini.
Concordo con Bacone per quanto riguarda la sua considerazione sulle funzioni della scienza: le scoperte tecnologiche permettono agli uomini di progredire, migliorare e avvicinarsi ad un grado di conoscenza più approfondito, liberandosi di inutili pregiudizi (gli idola baconiani).
Perciò secondo me è fondamentale che ogni società possieda degli scienziati propri, che con le loro scoperte possano far evolvere la condizione dell’intera comunità; ma con il termine “scienziati” voglio intendere non solo coloro che lavorano in ambito scientifico-tecnologico, ma chiunque sia dotato di un sapere specifico che possa costituire un vantaggio per la società. Proprio per questo, al contrario di Bacone, penso sia utile una stretta collaborazione tra scienza e politica: infatti ritengo corretto non svelare le ricerche innovative a tutti gli abitanti per assicurarsi che nessuno possa utilizzarle in modo improprio, ma ritengo anche importante che i politici (ovviamente solo quelli che cercano di raggiungere il bene pubblico, non quello personale) possano trarre insegnamenti da tutto il lavoro eseguito dagli scienziati, in modo da governare meglio, con maggiori conoscenze e consapevolezze, così favorendo una società più organizzata.